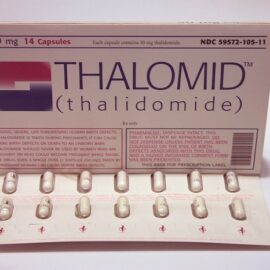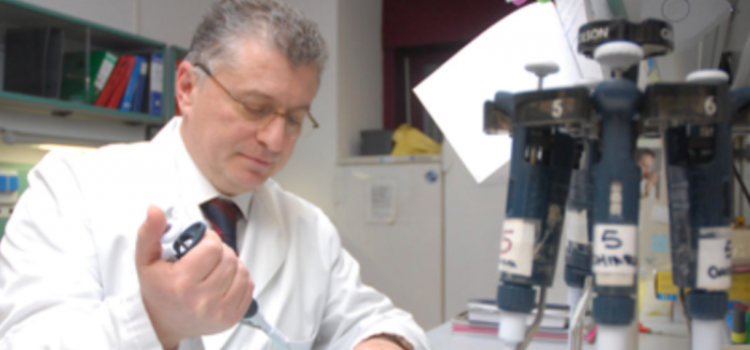
Il genetista Giuseppe Novelli: «Vi spiego perché muoiono i vaccinati»
Di Alessandro Rico – Il genetista coautore di un studio internazionale: «In rianimazione spesso finisce chi non produce o non riesce a usare l’interferone, la prima linea di difesa antivirus. Il governo organizzi uno screening dei soggetti a rischio».
Perché i vaccinati possono ammalarsi gravemente e morire di Covid? Una spiegazione l’ha appena fornita uno studio, uscito su Science Immunology e condotto da un grande consorzio internazionale, coordinato dalla Rockfeller University di New York, cui hanno partecipato l’Asst Spedali Civili di Brescia, l’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, il Bambino Gesù e l’Università di Roma 2. Ce lo siamo fatto spiegare bene da uno degli autori, Giuseppe Novelli, stimato genetista e responsabile della genetica medica al Policlinico Tor Vergata.
Professore, ci illustra in termini semplici la vostra ricerca?
«Già all’inizio della pandemia eravamo rimasti colpiti dal fatto che, sebbene tutti fossero stati contagiati dallo stesso virus, il 40% degli infetti era asintomatico, il 10-12% aveva sintomi leggeri, il 5-10% finiva in ospedale e circa il 2% in terapia intensiva. Ma se il virus è il medesimo, significa che la differenza la fanno l’ospite e la sua genetica».
Fin qui, una deduzione logica. Che cosa avete dimostrato, quindi?
«Che una buona quota dei pazienti che finiscono in terapia intensiva, tra il 3 e il 10%, ha un problema genetico preesistente: non produce l’interferone o non riesce a utilizzarlo».
Cos’è l’interferone?
«È praticamente la nostra prima linea di difesa contro ogni virus e ogni batterio. Fa parte di quella che noi chiamiamo “immunità innata”. Alla famiglia degli interferoni, poi, si collegano le citochine, quelle che, quando intervengono in maniera troppo massiva, provocano un danno infiammatorio».
La famosa tempesta citochinica, che si scatena nei malati di Covid gravi?
«Esatto. È connessa al mancato o difettoso intervento dell’interferone: se la prima linea di difesa non funziona, si attivano massicciamente le seconde e le terze, scatenando così la tempesta citochinica».
Il fuoco amico.
«Che fa più danno, perché a far male non è il virus in sé, bensì, appunto, la reazione infiammatoria».
Torniamo all’interferone.
«Potremmo quasi dire che il Covid sia un’interferonopatia, un gruppo di patologie scoperte nel 2011».
Ci spiega perché il problema riguarda anche i vaccinati?
«Noi facciamo affidamento su due tipi d’immunità: quella innata e quella acquisita, che a sua volta si ottiene o con il vaccino o con l’infezione. Le due immunità, però, devono lavorare insieme; se una è squilibrata, il sistema può incepparsi».
Il problema dei vaccinati, dunque, non era che non producevano anticorpi nonostante l’iniezione?
«La risposta anticorpale era normale. Abbiamo scoperto però che, oltre a una quota di pazienti che non produce l’interferone, ce n’è un’altra, che arriva fino al 20%, di soggetti che producono l’interferone, ma non lo utilizzano».
Perché?
«Perché lo distruggono con gli autoanticorpi. È un problema autoimmune. Negli individui sani, questi autoanticorpi sono molto rari: li abbiamo trovati nello 0,17% di loro. Se ne trovano di più negli over 70, anche se sani: circa il 4%».
È uno dei motivi per cui gli anziani sono più esposti al Covid?
«Esatto. Negli anziani malati di Covid, infatti, li abbiamo trovati in quantità piuttosto elevate: gli autoanticorpi erano nel 20% dei deceduti per il Sars-Cov-2. Il virus, dunque, è un “trigger”, fa da innesco per la stimolazione di questi autoanticorpi, che però esistevano già prima della pandemia».
E tutto il discorso che si fa sulle comorbidità?
«Be’, gli autoanticorpi li abbiamo individuati, come le dicevo, nel 20% dei soggetti morti di Covid. Persino in un paziente giovanissimo, di 12 anni. Negli altri casi, di solito, a facilitare un esito infausto della patologia sono altri problemi: diabete, obesità, malattie cardiovascolari…».
È possibile scoprire chi è che ha questo difetto genetico relativo all’interferone?
«Certo, per gli autoanticorpi è sufficiente un banale test di laboratorio, che si esegue sul siero. Basta avere il kit e i reagenti. Per scoprire le mutazioni dei geni dell’interferone, invece, bisogna leggere il Dna e ciò richiede qualche competenza in più».
Non sarebbe opportuno, allora, che il ministero incoraggi uno screening sulla popolazione? Individueremmo un ulteriore fattore di rischio e, magari, una fetta di popolazione da proteggere…
«Be’, io faccio lo scienziato. Sono i politici che devono decidere…».
Lei può dare suggerimenti tecnici.
«Più che pubblicare questa ricerca! Io dico che questo test sarebbe importante, perché alcuni colleghi americani e spagnoli hanno appena scoperto anche che chi ha quegli autoanticorpi anti interferone rischia non solo per il Covid, ma pure per la riattivazione di virus latenti, come l’herpes. È necessario individuare i soggetti più esposti, studiarli in maniera selettiva, approntare terapie specifiche: la medicina del futuro è una medicina di precisione, personalizzata».
Nel paper scrivete che gli individui con questo difetto genetico possono trarre beneficio dalle vaccinazioni ricorrenti. Ma se non sono bastate né due né tre dosi, come può la quarta cambiare tutto?
«La risposta immunitaria è duale, appunto: innata e acquisita. Se hai un difetto nella risposta innata, puoi compensare rafforzando quella acquisita. Perciò la quarta dose può essere utile, anche se il virus elude il vaccino e ci si infetta lo stesso».
E l’anergia del sistema immunitario, causata da troppe dosi ravvicinate?
«Ad ora, i dati sulla quarta dose, specie da Israele, dicono che una risposta immunitaria c’è. Per il futuro dovremo capire, bisogna acquisire ulteriori dati».
Nel saggio parlate di monoclonali e antivirali. Le cure precoci sono importanti?
«Assolutamente, tant’è che la terapia precoce con i monoclonali, su alcuni bambini che avevano difetti nei geni dell’interferone trattati negli Usa, ha dato ottimi risultati. I monoclonali sono farmaci d’eccellenza. Il loro unico svantaggio è che sono altamente specifici; e infatti, quelli calibrati sul virus di Wuhan non sono efficaci per il ceppo di Omicron. Ma c’è una novità».
Quale?
«I monoclonali di terza generazione: sono anticorpi modificati».
In che modo?
«Gliela faccio semplice: di solito hanno due “attacchi”; se io gliene metto quattro, si moltiplica la capacità di legare il virus, anche quando muta. E non c’è bisogno di ricostruire ogni volta l’anticorpo a partire dalla “libreria” dei monoclonali sintetici. Basta anche prendere quello tarato sul ceppo di Wuhan e poi modificarlo. Insomma, anziché partire dalla libreria, parto dal libro e cambio solo qualche pagina. Noi abbiamo già cominciato la sperimentazione sugli animali».
In quanto tempo saranno pronti i nuovi monoclonali?
«Qui casca l’asino».
In che senso?
«Con i fondi della ricerca noi produciamo la molecola; dopodiché la molecola deve diventare farmaco. E per quello ci vuole l’industria, ci vogliono le grandi organizzazioni strutturate che solo potentati economici, come la Pfizer, si possono permettere».
Immaginiamo…
«Calcoli, ad esempio, che a ogni volontario umano che si sottopone a una sperimentazione va garantita l’assicurazione sulla vita; e Pfizer, per il primo vaccino, ha usato 30.000 volontari…».
Quanti soldi servirebbero, insomma?
«La mia ricerca sui monoclonali è costata qualche milione di euro. Per produrne poche dosi necessarie alla sperimentazione su 100, 150 persone – non per la fabbricazione su larga scala, dunque – serve un’industria che investa altri 5-6 milioni di euro. Allora, o il privato ci mette su un capitale, oppure deve intervenire il pubblico, anche in partnership con il privato».
Visto che l’ospite è tanto importante, lei crede che la genetica abbia a che fare anche con le reinfezioni? Ci sono soggetti più predisposti a contagi multipli?
«È un deaglio che si sta studiando. Teoricamente, l’ipotesi ha senso. Per le stesse ragioni, con i colleghi di New York, stiamo facendo partire un progetto mondiale per tentare di capire come mai, ad alcune persone, il vaccino provoca le miocarditi, mentre ad altre no. Può darsi ci sia una suscettibilità genetica».
Promettente…
«Le dico solo che alcuni colleghi del Nevada hanno scoperto che, nei soggetti che hanno reagito alla vaccinazione con la febbre, era più frequente la variazione in un gene che noi chiamiamo Hla. E un’altra cosa che ci piacerebbe comprendere è perché il 30% dei guariti poi soffre di long Covid».
Sempre questione di genetica?
«È fortemente probabile».
La Verità
Fonte : LA PEKORANERA